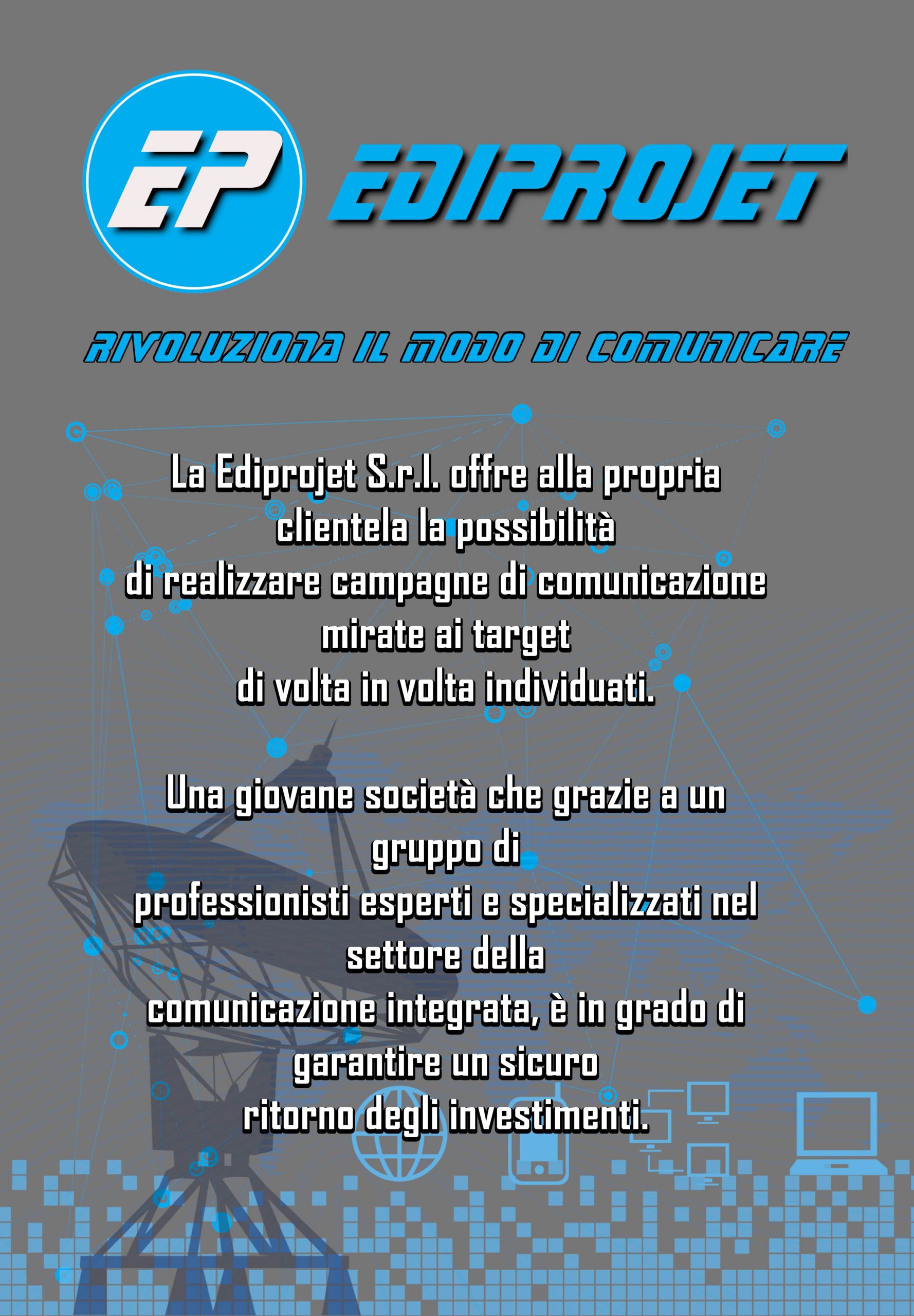Cassazione tombale, respinto ricorso di Zonin contro la sanzione Consob
Con l’ordinanza 25439 del 2025, pubblicata a fine settembre, la Cassazione non chiude solo un ricorso, ma un’epoca: quella dei presidenti che potevano “non sapere”. Giovanni Zonin, ex numero uno della Banca Popolare di Vicenza, condannato in via definitiva a 3 anni 5 mesi di reclusione per aggiotaggio e falso in prospetto, chiedeva l’annullamento della sanzione Consob da 40 mila euro per le omissioni nei prospetti informativi del 2014-2015. La Suprema Corte ha detto no, e lo ha fatto con una formula destinata a pesare nel tempo: chi guida una banca deve sapere, e se non sa, deve dimostrare perché non poteva sapere. Soprattutto, come nel caso di BpVi, se aveva oltre 100 mila soci sparsi in diverse regioni italiane (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Puglia e Sicilia) ed a fine giugno 2017 era insolvente per un crac da 6 miliardi di euro.
Non basta più appellarsi alle deleghe, alla fiducia nei tecnici o alla complessità delle strutture. Per i supremi giudici, il presidente di un istituto di credito non è un garante simbolico ma parte integrante del sistema di controllo interno. Zonin, dunque, non poteva ignorare il fenomeno del cosiddetto capitale finanziato (le “baciate”), vale a dire le azioni della Popolare acquistate da soci e clienti grazie a prestiti concessi dalla stessa banca per gonfiarne la domanda ma mettere in discussione il capitale di rischio, né poteva nascondersi dietro i silenzi dei collaboratori. Il suo nome e la sua firma sui prospetti bastavano a fondare la responsabilità.
La linea è chiara: la colpa si presume, l’ignoranza non scusa, la delega non salva. È un cambio culturale che abbatte la vecchia prassi dei “padri nobili” delle banche popolari, presidenti rispettati ma distanti dalla gestione reale. La Corte sancisce che l’epoca della non conoscenza istituzionale è finita.
Ma per capire la portata di questa decisione, bisogna affiancarla a un’altra: la sentenza di luglio 2025, con cui la stessa Cassazione ha confermato in via definitiva lo stato di insolvenza della Popolare di Vicenza al momento della liquidazione. Un pronunciamento che chiude anni di contenziosi e sancisce una verità tecnica e morale insieme: la banca non è fallita per caso, né per un cambio di clima regolatorio. Era già malata dentro, corrosa da scelte gestionali sbagliate e da una cultura aziendale autoreferenziale.
Le due sentenze, prese insieme, ridisegnano la mappa della responsabilità bancaria. Da un lato, l’istituzione che si scopre insolvibile. Dall’altro, il suo presidente che non può invocare la buona fede per le omissioni. In mezzo, un sistema di controllo che per anni ha preferito il silenzio alla trasparenza.
Il collegamento tra le due pronunce è forte. L’una fotografa la rovina della banca; l’altra, la cecità di chi la guidava. La Cassazione costruisce un filo logico: se un istituto collassa, e se i suoi vertici hanno taciuto sulla reale esposizione, la responsabilità non è collettiva ma diretta. La non conoscenza diventa colpa.
Dietro le formule giuridiche c’è la sostanza di una lezione morale. La finanza, dice la Corte, non può nascondersi dietro l’apparenza dei numeri. La verità economica è un dovere etico. E il dovere di informare corre parallelo a quello di amministrare. Chi guida un’istituzione che vive sulla fiducia dei soci non può più usare la nebbia organizzativa come schermo.
C’è poi un significato più profondo. Le due decisioni arrivano in un momento in cui il Nordest, ancora ferito dai crac di BPVi e Veneto Banca, tenta di ritrovare fiducia. Decina di migliaia di piccoli risparmiatori hanno perso tutto credendo in un sistema che prometteva solidità e sicurezza. Oggi la giustizia restituisce almeno la certezza di una responsabilità individuata, di una verità giudiziaria che chiude le porte all’oblio.
Non è una vendetta, ma una ricostruzione. L’insolvenza accertata e la sanzione confermata tracciano un confine: da una parte, chi ha creduto nella banca; dall’altra, chi l’ha guidata senza controllarla davvero. È la fine dell’alibi che per anni ha protetto i vertici: non sapevamo, non potevamo sapere. Ora quel tempo è finito. Le banche, d’ora in avanti, dovranno ripensare i propri modelli di governance. La “compliance” formale non basta più: servono vigilanza reale, flussi informativi trasparenti, controlli indipendenti. Il presidente non è più una figura di rappresentanza, ma un garante della verità.
Gianni Zonin, 87 anni, resta un simbolo di quella stagione del credito territoriale che aveva fatto grande il Veneto e poi ne ha minato le fondamenta. Il suo nome, un tempo sinonimo di potere e radicamento, oggi evoca il prezzo della fiducia mal riposta. Le sentenze non cancellano la sua storia, ma la completano: mostrano come la cultura della crescita senza controllo possa trasformarsi in rovina. Il messaggio della Cassazione è netto e universale: nei vertici bancari, il confine tra colpa e ignoranza è sottile come la carta di un prospetto. Chi firma, risponde. E chi rappresenta la fiducia di migliaia di soci non può più rifugiarsi dietro il “non sapevo”. Le due sentenze del 2025 chiudono un ciclo e aprono una nuova stagione di responsabilità diffusa. Perché se Zonin non poteva non sapere, ma non è vero sul piano penale, da oggi nessun presidente potrà più dirlo.
Torna alle notizie in home