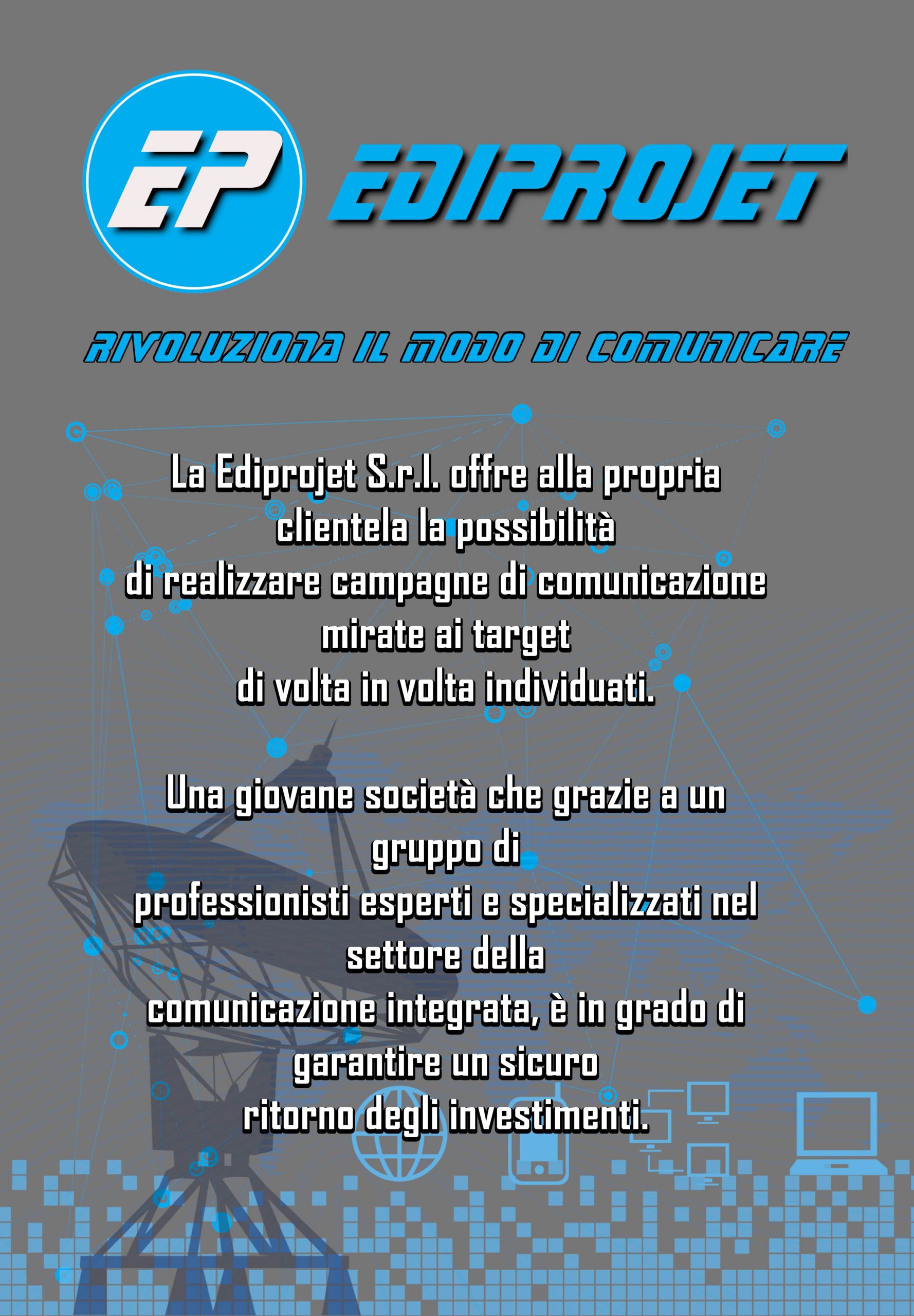Chi di lavoro ferisce
Tommaso Cerno
di TOMMASO CERNO
Un Paese come l’Italia che è cresciuto negli ultimi 80 anni appoggiandosi sulla base sempre più larga della sua classe media si interroga oggi sulla rabbia sociale, proprio quando il crollo di questa economia di mezzo è sancito dai fatti e dalle statistiche. Alla vigilia di un nuovo scontro fra ricchi e poveri. Senza più il volano sociale e culturale come appiglio per tentare di migliorare la propria condizione, di costruire quel famoso futuro migliore dei propri genitori che ha determinato la crescita e la visione verticale dell’Italia fino a pochi anni fa.
Domandarsi perché oggi un’intera generazione più giovane fatica a entrare nel meccanismo sociale è come domandarsi perché i pesci soffocano in un acquario avvelenato. Il lavoro fin dalla nascita della Repubblica è stato fondamento non solo culturale della nostra Costituzione ma materiale della costruzione della società. Aveva in sè la natura della identità sociale, garantiva una strada a diversi livelli capace di portare il singolo individuo dentro al corpo sociale e di consentirgli di avanzare all’interno di percorsi sopra i quali veniva progettato il futuro, professionale e familiare su un arco di tempo di almeno tre decenni. Il lavoro di cui parliamo oggi ha perso questa connotazione.
È un sinonimo di mansione e non più di occasione, fatica a garantire la sopravvivenza ed è sempre più lontano dall’essere l’inizio di un percorso le cui direzioni e profondità dipenderanno poi dalle capacità e dalle scelte di ognuno. Milioni di ragazze e ragazzi italiani hanno vissuto l’infanzia e l’adolescenza nel convincimento di aderire al rinnovamento di questo patto sociale, in un mondo nuovo, dentro il quale le esperienze passate avrebbero lentamente lasciato il posto alle competenze future. Ciò che invece all’improvviso la nostra società chiede è un effetto puzzle, dove i giovani devono essere pronti a prendere la forma dello spazio che casualmente la società lascia loro, a fronte di condizioni che possono essere anche ragionevoli sul piano statistico, ma mancano del tutto di quell’ancoraggio nel movimento della società che spinge a immaginare il percorso dell’inizio come una fatica utile a inseguire e realizzare un sogno, trasformandola invece in un senso di servitù per terzi il cui sogno è già realizzato.
In un quadro così parlare di soldi, e siamo nel paese con i salari più bassi rispetto alle nazioni che ci somigliano, non è inutile ma è superfluo. E lo è perché la condizione reale in cui ci troviamo è quella di una caccia al necessario in cambio dell’indispensabile. Dove il necessario è chi lavora e l’indispensabile è quel minimo compenso che sulla carta sembra una retribuzione ragionevole ma calata nella realtà basta sì e no a coprire le spese per lo stesso periodo in cui si svolge la mansione.
Con una base di questo tipo l’Italia rischia di doversi davvero affidare ad altri per completare la fase produttiva che stiamo vivendo, fatta di enormi altezze e grandi ricchezze nelle mani di pochi di fronte a un impoverimento generale e a una società bassa sempre più ampia e grigia. Immaginare che l’Europa, cioè la nostra prospettiva di sviluppo, su questo tipo di terreno faccia piovere tasse e tasse è la prova che l’obiettivo delle nostre istituzioni non è quello di un rilancio della capacità sociale di autoalimentarsi e di progredire ma quello di coprire debiti e pretese finanziarie attorno alle quali si è sviluppata la politica di crescita industriale dell’ultimo decennio.
Torna alle notizie in home