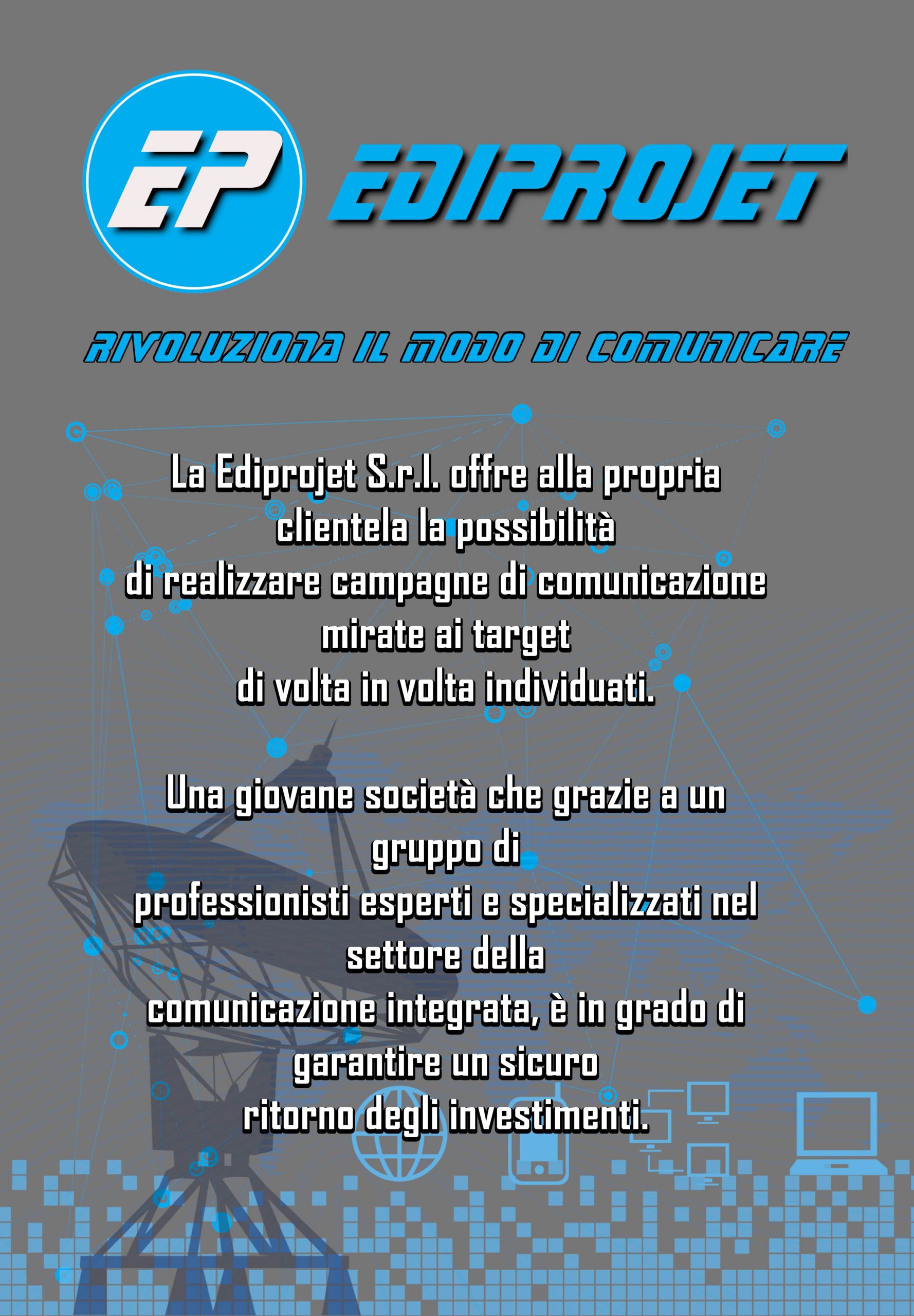13enne morto di tumore. I genitori citati a giudizio ma la difesa nega i rifiuti
Sono stati rinviati a giudizio i genitori di Francesco, il tredicenne vicentino di Costabissara del 2009 morto a causa di un tumore che non ha lasciato scampo. La Procura ipotizza per loro l’accusa più grave: omicidio volontario aggravato. Secondo i magistrati, la coppia non avrebbe fatto curare in tempo il figlio, rinunciando alle terapie salvavita e compromettendo definitivamente le possibilità di sopravvivenza sostenendo che fossero in qualche modo seguaci di Hammer. Un quadro drammatico, che però la difesa contesta con forza. “Non è vero che le chemio siano state rifiutate – chiarisce l’avvocato Lino Roetta (nella foto), difensore dei genitori -. La ricostruzione è diversa: il ragazzo era già in una condizione di gravità estrema. Si erano presi due o tre settimane prima di affrontare un trattamento particolarmente pesante, ma non c’è stato alcun rifiuto”. Secondo l’impostazione accusatoria, i genitori avrebbero omesso di avviare subito il protocollo indicato dagli oncologi, preferendo rivolgersi ad altri pareri medici e rinviando la decisione. Una scelta che per la Procura equivarrebbe a un comportamento doloso, volto a sottrarre il minore a cure indispensabili. Ma per la difesa il percorso seguito dalla famiglia è stato quello di tanti altri pazienti: “Dopo la diagnosi – spiega Roetta – i genitori si misero con senso di responsabilità, consultando specialisti e valutando i pro e i contro di una chemioterapia che, alla luce delle condizioni cliniche, non avrebbe comunque garantito risultati. Non si è trattato di un rifiuto ideologico né di abbandono terapeutico, ma di un confronto complesso, vissuto nell’angoscia di chi deve decidere in pochi giorni della vita di un figlio”. La linea difensiva insiste sul fatto che, già al momento della diagnosi, le possibilità di guarigione erano nulle. “Si parla di cure pesantissime – aggiunge Roetta – con effetti collaterali devastanti e pochissime chance di successo. Per questo i genitori hanno chiesto tempo: volevano capire se sottoporre il figlio a un percorso che lo avrebbe ulteriormente provato senza reali possibilità di salvarlo”. La vicenda ha spaccato l’opinione pubblica. Da una parte, chi sottolinea che un ritardo, anche minimo, possa aver compromesso l’efficacia delle cure; dall’altra, chi vede nell’accusa un eccesso punitivo nei confronti di due genitori già travolti dal dolore più grande. “La perdita di un figlio – osserva Roetta – è una tragedia insopportabile. Trasformarla in imputazione penale di omicidio volontario è una forzatura che non tiene conto né della scienza né della realtà clinica”. Il processo davanti alla Corte d’Assise stabilirà se la scelta di attendere alcune settimane possa essere equiparata a un rifiuto. Ma, come rilevano diversi esperti, nei casi in cui la malattia è già in fase avanzata, i margini di successo delle terapie si riducono drasticamente. “Non si può addossare a questi genitori – conclude Roetta – la responsabilità di una morte che purtroppo era già scritta nella diagnosi. Hanno fatto tutto ciò che era possibile fare, in scienza e coscienza”. Ora la parola passa ai giudici. Saranno loro a decidere se quei giorni di esitazione rappresentino davvero un comportamento penalmente rilevante o se, come sostiene la difesa, non abbiano mutato un destino già segnato.
Torna alle notizie in home