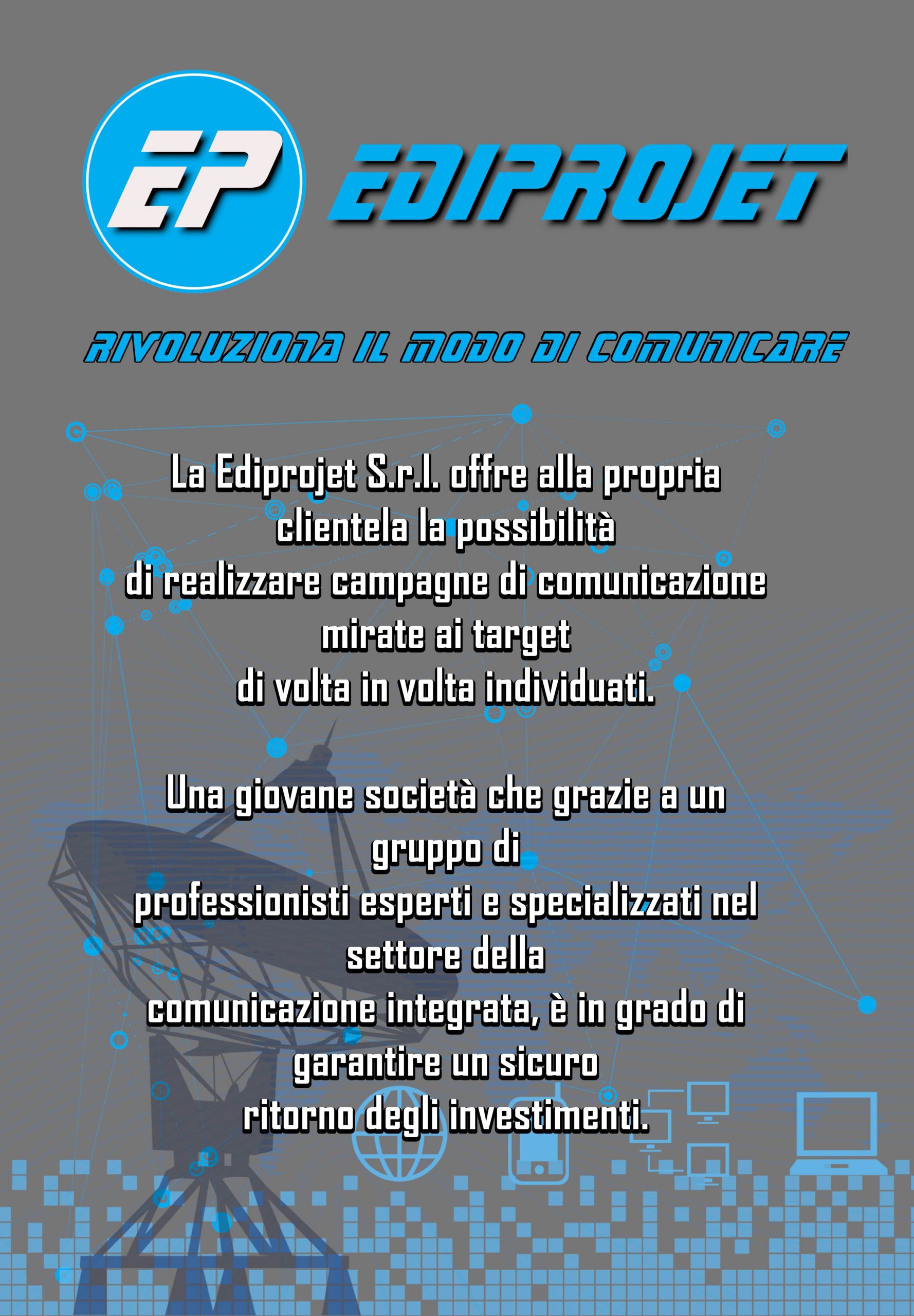Crans-Montana: sei settimane sottozero
Intervista ad Alessandro Politi inviato di RAI1 della trasmissione “Storie Italiane” e “1Mattina News” che prova a penetrare il muro di gomma congelato dal freddo elvetico.
Da più di quaranta giorni Alessandro Politi, “enfant prodige” del giornalismo investigativo e d’inchiesta, cammina in un posto dove il freddo non è meteo: è metodo. A Crans-Montana la neve cade dritta, le risposte no. Le istituzioni parlano poco e dicono meno. I silenzi non coprono: respingono. Qui il gelo non punge, non sorprende, non consola. Esclude.
Politi resta.
Resta quando le versioni ufficiali si sciolgono come neve al sole. Resta quando ogni passo sembra un disturbo, un rumore fuori posto in un territorio che non vuole testimoni. Lo fa perché il suo lavoro non è scaldarsi: è capire chi produce il freddo e perché.
Questa intervista nasce lì, nel punto in cui il freddo smette di essere clima e diventa messaggio.
Sei settimane sottozero: cosa congela di più, il clima o le risposte che non arrivano?
Il freddo lo combatti con un cappotto pesante, il silenzio no. Le temperature rigide fanno parte del lavoro sul campo, le accetti. Quello che pesa davvero sono le risposte che non arrivano, le mail senza seguito, le richieste formali che restano sospese. Non per una questione personale, ma perché ogni ritardo, in un’indagine su 41 morti, non è mai neutro. Il tempo, quando si cercano responsabilità, è un elemento cruciale.
C’è un momento preciso in cui hai capito che questa non era solo una tragedia, ma un sistema che scricchiola?
Sì. Quando ho iniziato a incrociare le date. Segnalazioni, controlli, autorizzazioni, finanziamenti, verifiche. Tutto apparentemente corretto all’inizio, almeno sulla carta. Ma nella realtà qualcosa non tornava. Non si è trattato di un singolo errore, ma di una sequenza di omissioni, ritardi, passaggi poco chiari. È lì che capisci che non stai più guardando solo un incendio, ma una filiera di responsabilità che merita di essere raccontata con precisione chirurgica.
Le istituzioni svizzere sono famose per la precisione. Qui, invece, sembra tutto un fuori fuoco. Da giornalista d’inchiesta, come si affronta un Paese quando non vuole essere raccontato?
Con rispetto e con i documenti. Io non faccio processi mediatici, non anticipo sentenze. Lavoro sugli atti, sulle risposte ufficiali, sulle contraddizioni oggettive. Non esiste un Paese che non voglia essere raccontato, esistono contesti in cui l’accesso alle informazioni è più complesso. Il compito del giornalista è restare super partes, insistere con metodo, senza forzature e senza pregiudizi. La credibilità è l’unico strumento che abbiamo, altrimenti diventa un Farwest.
Hai parlato con fornitori, tecnici, famiglie, testimoni. Chi ti ha detto la verità senza volerla dire?
Spesso la verità emerge nei dettagli secondari, non nelle dichiarazioni solenni. Un tecnico che ti spiega una procedura “come si fa di solito”, un fornitore che racconta una scelta fatta per risparmiare, un familiare che ricorda una porta chiusa o una luce spenta. Nessuno pensa di fare una rivelazione, ma quei frammenti, messi insieme, costruiscono un quadro più chiaro di qualunque slogan.
È anche vero che l’intervista che ho realizzato al fornitore degli arredi del Le Constellation nel 2015 mi ha profondamente scosso. Non per sensazionalismo, ma per la coerenza e la gravità degli elementi che ha messo in fila. Se quei fatti trovassero pieno riscontro documentale e giudiziario, lo scenario delle responsabilità potrebbe cambiare radicalmente, spostandosi da una colpa cosciente o da una grave negligenza verso ipotesi ancora più pesanti come il dolo eventuale.
Ciò che colpisce in modo ancora più forte è un altro aspetto: questa persona sostiene di aver scritto più volte alla polizia municipale, alla polizia cantonale e anche ai procuratori, mettendo nero su bianco circostanze precise. Eppure, riferisce di non essere mai stato convocato né formalmente ascoltato per lungo tempo. In un’indagine di questa portata, con decine di vittime, è un dato che oggettivamente sorprende e che merita chiarimenti.
A questo si aggiunge un elemento umano molto duro: durante la fase di consegna dei mobili, a fronte di ritardi, racconta di aver ricevuto minacce pesantissime, frasi come “ti spezzo gambe e braccia”. Sono dichiarazioni che vanno verificate con la massima cautela e nel rispetto della presunzione di innocenza, ma che, se confermate, delineerebbero un clima tutt’altro che ordinario già anni prima della tragedia.
In altre tue inchieste, penso ad esempio al caso Bergamini o ThyssenKrupp che hai seguito in Italia, la verità era nascosta o semplicemente non guardata? Qui cosa cambia?
Nel caso di Denis Bergamini per anni la verità è stata non guardata con la dovuta profondità. Nel rogo ThyssenKrupp le responsabilità sono emerse attraverso un lungo percorso giudiziario, ma all’inizio c’era una sottovalutazione dei segnali di rischio. Qui la differenza è il contesto internazionale e la forte fiducia nel sistema di controllo. Quando un sistema è percepito come impeccabile, è ancora più difficile accettare l’idea che qualcosa possa non aver funzionato.
C’è un dettaglio minuscolo, apparentemente irrilevante, che ti ha fatto più male di tutto il resto?
Sì. E non riguarda un atto giudiziario o un documento tecnico. Riguarda un episodio umano. L’aggressione immotivata e molto violenta che ho subito da alcuni soggetti, che si sono qualificati come dipendenti dei Moretti, è stato un momento che mi ha colpito profondamente. Non tanto per la paura, che fa parte del mestiere quando ti occupi di vicende delicate, ma per il clima che quella reazione raccontava.
E poi c’è stato un altro aspetto, più sottile ma altrettanto doloroso. Il modo in cui sono stato trattato, in alcuni casi, da albergatori, baristi o residenti svizzeri. Nel momento in cui capivano che ero un giornalista italiano e che stavo lavorando sull’inchiesta, l’atteggiamento cambiava. Sguardi di diffidenza, risposte brusche, porte che si chiudevano. Non sempre, ovviamente, ma abbastanza da percepire un disagio.
Non lo dico con spirito polemico. Lo dico con onestà. Fare il giornalista significa anche accettare di non essere benvoluti. Ma essere guardato con disprezzo solo perché cerchi di fare domande, e perché vieni da un altro Paese, è qualcosa che lascia un segno. Non personale, ma professionale. Perché ti ricorda quanto sia fragile l’equilibrio tra il diritto di cronaca e la paura di essere raccontati.
Raccontare una tragedia significa anche convivere con chi non vuole che tu la racconti. Qual è stato il momento più “sottozero” nei rapporti con chi avrebbe dovuto collaborare?
Il momento più difficile è quando percepisci chiusura, non ostilità esplicita ma distanza. Richieste legittime che vengono rimbalzate, domande che ricevono risposte parziali. Non lo vivo come uno scontro personale. È una fase fisiologica delle inchieste complesse. Ma certo, quando lavori sul campo e sai che ogni informazione può essere decisiva, quella freddezza istituzionale si sente.
Quando tornerai in Italia, cosa ti porterai dietro da Crans-Montana: un’inchiesta, una ferita o altro?
Mi porterò la responsabilità di aver raccontato fatti verificati, nel rispetto della presunzione di innocenza e delle vittime. Ogni tragedia lascia una traccia personale, sarebbe disumano il contrario. Ma soprattutto mi porto la consapevolezza che il giornalismo serve proprio a questo: non a puntare il dito, ma a fare luce. E la luce, anche quando è scomoda, è un dovere civile.
Leggi anche: Jessica Moretti confessa: “Mai fatte prove di evacuazione”
Torna alle notizie in home