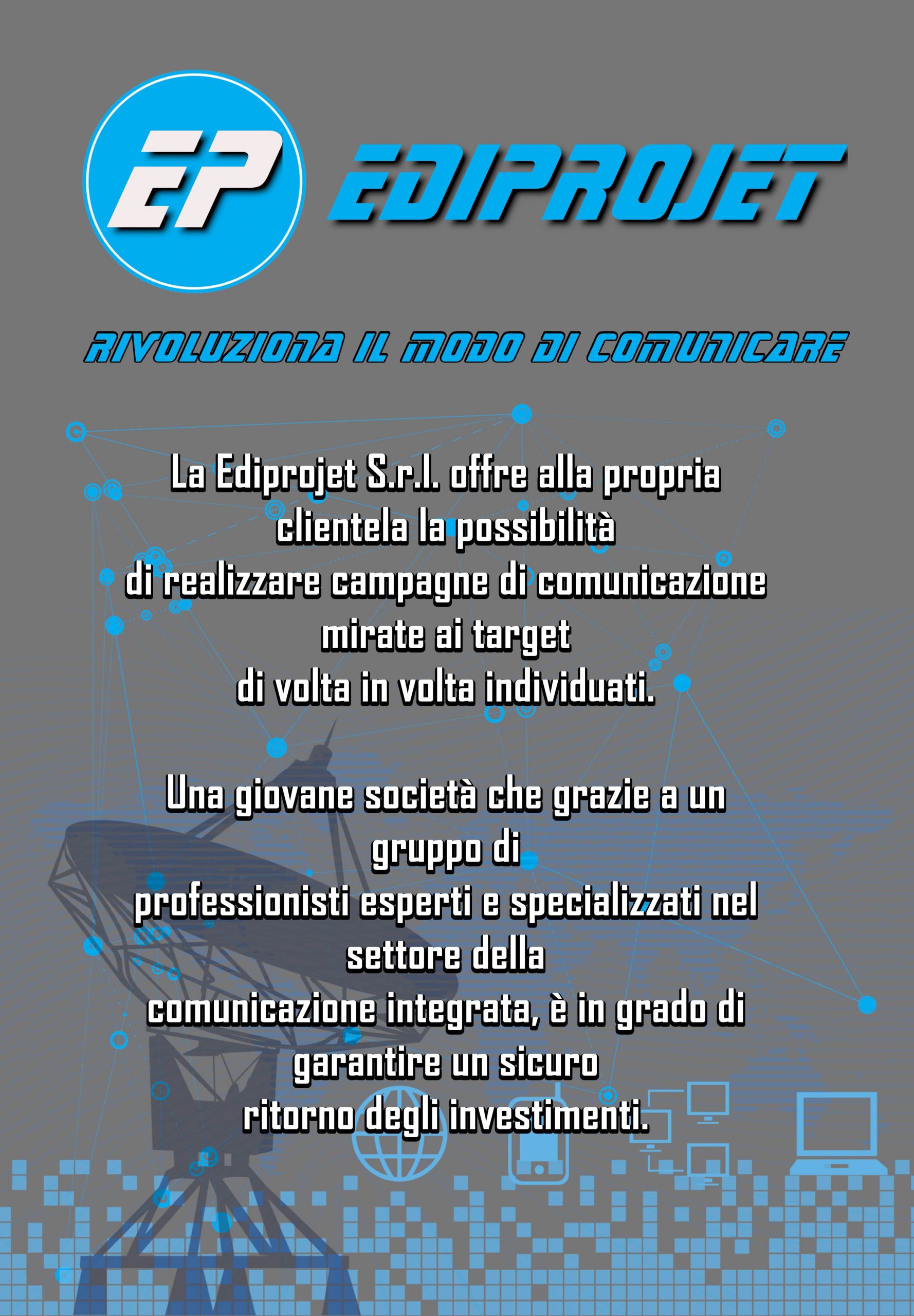Giustizia, carriere e terzietà: il nodo irrisolto. Intervista a Andrea Cangini
Andrea Cangini, giornalista ed ex senatore, (comitato Sì separa) analizza la riforma della giustizia e il significato della separazione delle carriere come garanzia concreta dei diritti dell’imputato e del giusto processo.
La separazione delle carriere è spesso letta come una riforma di assetto ordinamentale. In che misura, invece, essa incide sulle garanzie del cittadino e sul principio di terzietà del giudice nel processo?
“Tanto per cominciare, credo sia utile ricordare che l’unità delle carriere tra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti in Italia fu introdotta durante il Fascismo, e non è un caso che tutti gli ordinamenti dei Paesi europei, eccezione fatta per la sola Romania, prevedano la separazione. Si tratta di una misura volta a dare piena attuazione dell’articolo 111 della Costituzione, tutelando i diritti dell’imputato, la cui difesa viene messa non solo formalmente ma anche sostanzialmente al pari dell’accusa di fronte ad un giudice effettivamente terzo. In un Paese come il nostro, in cui ogni anno quasi mille persone vengono incarcerate per poi dimostrarsi innocenti, credo sia una misura di evidente civiltà giuridica”.
Dal punto di vista delle garanzie difensive, quanto è rilevante che la funzione requirente e quella giudicante siano affidate a carriere distinte e non comunicanti?
«Molto. Il fatto che oggi pubblici ministeri e giudici appartengano alla stessa corporazione fa si che si creino tra loro rapporti personali basati, a seconda dei casi, sull’amicizia o sulla complicità. Come dimostra il fatto che il 96% dei magistrati è iscritto all’Anm, partecipare alla vita associativa, e dunque imbrancarsi in questa o quella corrente, è l’unico modo che i magistrati hanno per aver riconosciuti i propri meriti e le proprie legittime ambizioni di carriera. Si è così determinato un sistema clientelare che nulla ha a che vedere con la giustizia e che rende di fatto “complici” giudici e pubblici ministeri. Separare radicalmente le due carriere è l’unica maniera per spezzare questo legame malsano e tutelare concretamente il diritto dell’imputato ad un giusto processo».
La riforma prevede Consigli superiori della magistratura distinti per giudici e pubblici ministeri. Perché questo assetto rafforza l’imparzialità del giudice senza comprimere l’autonomia della magistratura?
«La campagna dell’Associazione nazionale magistrati è palesemente falsa e diffamatoria. L’articolo 104 della Costituzione riformulato dal Parlamento è tale e quale al vecchio: “l’ordine giudiziario è autonomo e indipendente da ogni altro potere”, è scritto. Che un’associazione privata di funzionari pubblici che rappresentano un ordine dello Stato sostenga, con evidente malafede, che l’approvazione della riforma subordinerebbe i pubblici ministeri o addirittura i giudici all’esecutivo è gravissimo. Ma si può spiegare. Serve a mascherare il punto della riforma veramente indigesto per la magistratura associata: il sorteggio dei componenti dei due Csm. È infatti chiaro che nel momento in cui la scelta dei membri dei due Csm viene affidata al caso, il potere dei capicorrente verrebbe meno e con esso l’obbligo di fare vita associativa pur di non essere penalizzati nelle proprie ambizioni di carriera».
Il referendum sulla giustizia viene presentato come un passaggio di civiltà giuridica. Qual è, secondo lei, il nodo strutturale dell’attuale sistema che questa riforma intende finalmente correggere?
«Il nodo che viene sciolto è quello della potenziale complicità tra giudice terzo e pubblica accusa. Come non si stanca di ricordarci il presidente emerito della Corte costituzionale Augusto Barbera, una vita politica interamente consumata a sinistra, questa riforma nasce da lontano. Nel 1988, l’allora ministro della Giustizia Giuliano Vassalli, medaglia d’argento per la Resistenza, riformò il codice penale passando dal sistema inquisitorio a quello accusatorio. Da quel momento, secondo uno schema allora detto “alla Perry Mason”, accusa e difesa vengono posti sullo stesso piano. Ci vollero, però, altri dieci anni prima che il Parlamento adeguasse, con la riforma dell’articolo 111, la Costituzione alla novità. Era il 1999. Dopo 27 anni, siamo finalmente giunti ad adattare l’ordinamento giudiziario alla lettera della Costituzione repubblicana».
Leggi anche: Il Referendum non è un atto di fede né un calcolo politico
Torna alle notizie in home