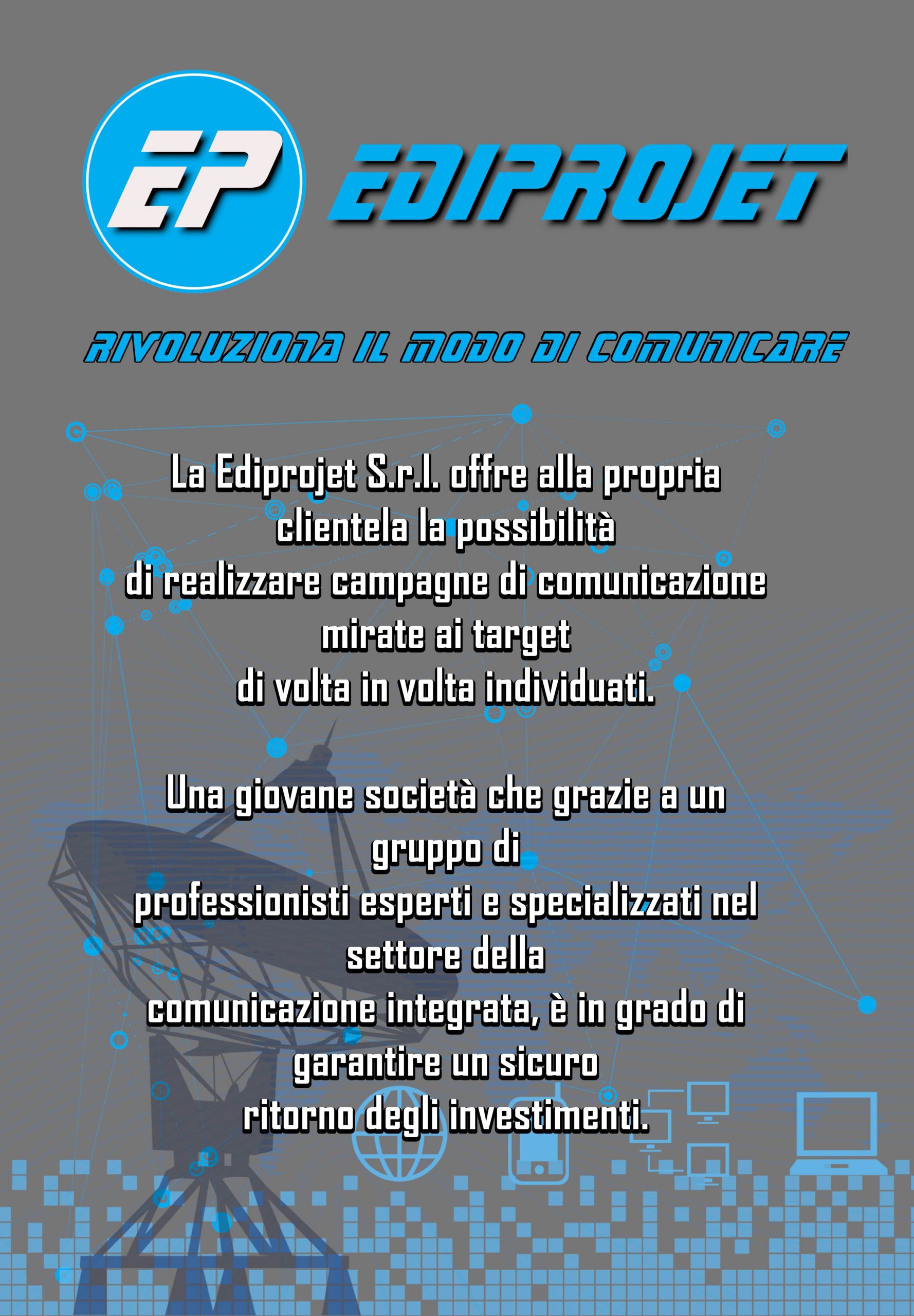Il Canto degli italiani: quel “Sì” che divide
C’è qualcosa di profondamente stonato – e non in senso musicale – nella decisione di intervenire sull’inno nazionale togliendo quell’ultimo “Sì!” gridato, diventato negli anni parte integrante dell’esecuzione pubblica del Canto degli Italiani. Un dettaglio? Tutt’altro. I simboli non vivono di dettagli, vivono di emozioni condivise, di rituali, di riconoscimento collettivo. E quel “Sì” finale, urlato negli stadi, nelle parate militari, nelle cerimonie ufficiali, non è mai stato un orpello: è stato un grido del cuore.
Premesso che l’inno ha una storia, una dignità e una continuità istituzionale, premesso che è stato cantato e rispettato da decine di Capi dello Stato prima di oggi, dalle istituzioni repubblicane e soprattutto dal popolo italiano nella sua interezza, viene spontaneo chiedersi con quale logica si decida ora di “correggerlo”. Non stiamo parlando di una revisione filologica per studiosi, ma di un gesto simbolico che incide su ciò che gli italiani sentono come proprio.
Per definizione costituzionale, il Presidente della Repubblica è una figura “irresponsabile”, cioè non politicamente responsabile dei propri atti. Ma qui viene il paradosso: solo un vero irresponsabile – nel senso più letterale e meno giuridico del termine – può pensare che sia una buona idea mettere mano a uno dei simboli più riconosciuti e condivisi della Nazione. Perché l’inno non appartiene ai palazzi, non appartiene ai protocolli, non appartiene ai manuali: appartiene alle persone.
Quel “Sì!” finale basta ascoltarlo durante un evento sportivo internazionale o in una cerimonia militare per capire cosa rappresenta. È l’urlo degli atleti che difendono il tricolore, è la voce dei militari che giurano fedeltà alla Repubblica, è l’emozione di milioni di italiani che, in quell’istante, si riconoscono come comunità. Togliere quel grido significa sterilizzare un sentimento, raffreddare un simbolo, trasformare un inno vivo in un esercizio da sala da concerto.
La motivazione? Sarebbe un presunto incitamento alla guerra. Ma per carità. Se davvero si arriva a leggere così un’espressione di orgoglio nazionale, allora il problema non è l’inno, ma lo sguardo ideologico con cui lo si osserva. Quel “Sì” non ha mai mandato nessuno al fronte: ha solo unito, emozionato, fatto battere il cuore un po’ più forte.
E allora, se proprio vogliamo cambiare l’inno, diciamolo chiaramente. Facciamo come quando Bossi, trent’anni fa, propose di sostituirlo del tutto. Ma cambiamolo davvero, non con piccoli interventi ipocriti e simbolicamente devastanti. Perché, parafrasando Fantozzi davanti alla Corazzata Potëmkin, questa operazione – chiamarla riforma sarebbe già un complimento – sembra proprio una cagata pazzesca.
Torna alle notizie in home