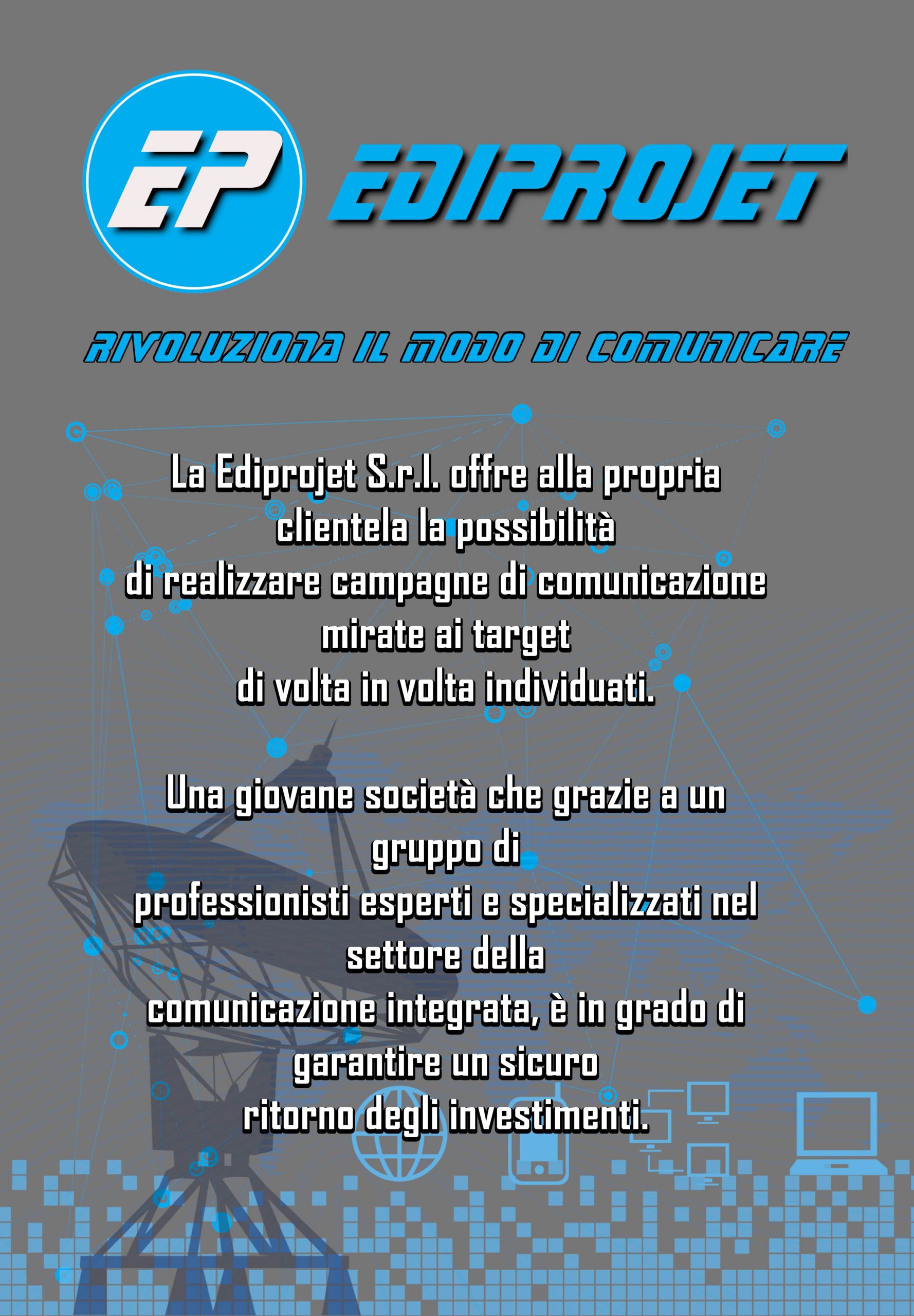Ospedali di comunità, la riforma che non funziona
Una misura che doveva cambiare il modo in cui gli italiani entrano in contatto con il sistema sanitario
Ospedali di comunità della sanità territoriale italiana: una promessa grande quanto il Paese, ma ancora sulla carta. Una riforma che doveva cambiare il modo in cui gli italiani entrano in contatto con il sistema sanitario. Meno strutture di pronto soccorso, meno ospedali congestionati, più cure vicino a casa. Una rete di prossimità capace di intercettare i bisogni prima che diventino emergenze.
Case e Ospedali di comunità, una riforma che non funziona ancora
L’idea, alla base di un decreto ministeriale del 2022 e della Missione 6 del Pnrr, che ha destinato oltre 15 miliardi di euro alla riorganizzazione dell’assistenza sanitaria. A metà del percorso, però, quella rete esiste soprattutto nei documenti di programmazione. Sul territorio, molto meno.
Il cuore della riforma, le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità. Le prime, pensate come presìdi sanitari di prossimità, facilmente accessibili, dove operano insieme medici di medicina generale, infermieri di comunità, specialisti ambulatoriali e assistenti sociali. L’obiettivo, la presa in carico continuativa dei pazienti cronici, la prevenzione, la riduzione degli accessi impropri agli ospedali.
Gli Ospedali di Comunità, invece, strutture di degenza breve per pazienti stabilizzati che non necessitano di cure ospedaliere acute ma non possono ancora rientrare a casa. Un disegno preciso. I numeri dell’attuazione lo sono altrettanto.
Numeri sconfortanti
Secondo i monitoraggi Agenas aggiornati al 2025, le Case della Comunità programmate sono 1.723. Quelle considerate “attive”, con almeno un servizio avviato, sono poco meno del 40 per cento. Ma solo una quota minima — poche decine su scala nazionale — rispetta pienamente gli standard previsti dal decreto: presenza medica strutturata, infermieri dedicati, apertura prolungata, integrazione con i servizi sociali.
In questo quadro diseguale, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna le regioni che “fanno meglio”, perché concentrano la quota più alta di Case della Comunità con almeno un servizio attivo rispetto alla programmazione. Ma proprio qui che serve una lettura meno celebrativa e più analitica: “fare meglio”, oggi, non significa ancora far funzionare pienamente la sanità territoriale.
Il caso del Veneto
Il primo caso emblematico, quello del Veneto. Secondo i dati regionali, oltre il 60 per cento delle Case della Comunità previste risulta attivo con almeno un servizio, così come più della metà degli Ospedali di Comunità programmati. Uno dei risultati quantitativamente più avanzati in Italia.
Ma molte strutture offrono servizi limitati nel tempo: ambulatori aperti pochi giorni a settimana, assenza di équipe multidisciplinari complete, integrazione ancora parziale con i medici di medicina generale. Il rischio, già segnalato dagli stessi report di monitoraggio, nel dato amministrativo di “attivazione” non coincidente a con un cambiamento reale nei percorsi di cura dei cittadini.
La situazione in Emilia-Romagna
In Emilia-Romagna, altro territorio indicato tra i più avanzati, una situazione più articolata. Qui una parte consistente delle Case della Comunità è effettivamente operativa e in alcuni distretti il modello di presa in carico funziona.
Ma anche in questa regione il risultato dipende fortemente dal contesto locale. Dove i medici di famiglia sono stati coinvolti in modo strutturale, la Casa della Comunità diventa un punto di riferimento reale.
Dove questo non è avvenuto, la struttura rischia di ridursi a un poliambulatorio riorganizzato, senza incidere davvero sulla domanda di ospedale. Il segnale che il nodo non è solo aprire edifici, ma cambiare l’organizzazione del lavoro sanitario.
In Lombardia più strutture ma…
Il terzo caso, la Lombardia che presenta il numero assoluto più elevato di strutture avviate. Anche qui la lettura richiede cautela. Le Case della Comunità dichiarate “attive” includono spesso presìdi con servizi minimi, non sempre conformi agli standard nazionali.
La complessità del territorio lombardo — grandi aree urbane, periferie dense, province molto diverse tra loro — amplifica le disuguaglianze. In alcune zone l’offerta territoriale cresce, in altre il cittadino continua a rivolgersi quasi esclusivamente all’ospedale. Tre casi per il paradosso della riforma. Anche dove i numeri sono migliori, la sanità territoriale resta fragile perché poggia su un elemento fragile: il personale. Medici di medicina generale, infermieri di comunità, specialisti ambulatoriali sono già oggi insufficienti. La riforma ne richiede di più, con competenze nuove e un’organizzazione diversa.
“I muri sono stati costruiti più velocemente dei servizi”, ha sintetizzato la Fondazione Gimbe, sottolineando come la carenza di professionisti rappresenti il principale collo di bottiglia dell’intero progetto.
Tutte le conseguenze, sui cittadini
Per i cittadini, conseguenze immediate. Dove la sanità territoriale non è pienamente operativa, il carico continua a ricadere sugli ospedali. Le cronicità restano poco seguite, l’assistenza domiciliare cresce meno del previsto, la prevenzione fatica a decollare. In molte aree del Paese, soprattutto fuori dai grandi centri urbani, la promessa di cure più vicine resta distante dalla vita quotidiana.
La riforma non come illusione e nemmeno come errore di impostazione: una trasformazione necessaria, sostenuta da risorse senza precedenti. Ma oggi il divario tra progetto e realtà è ancora evidente. Se non verrà colmato — investendo su personale, organizzazione e integrazione reale dei servizi — la sanità territoriale rischia di restare un’infrastruttura incompleta. Non un problema tecnico o amministrativo, un deficit che riguarda direttamente i cittadini.
Torna alle notizie in home