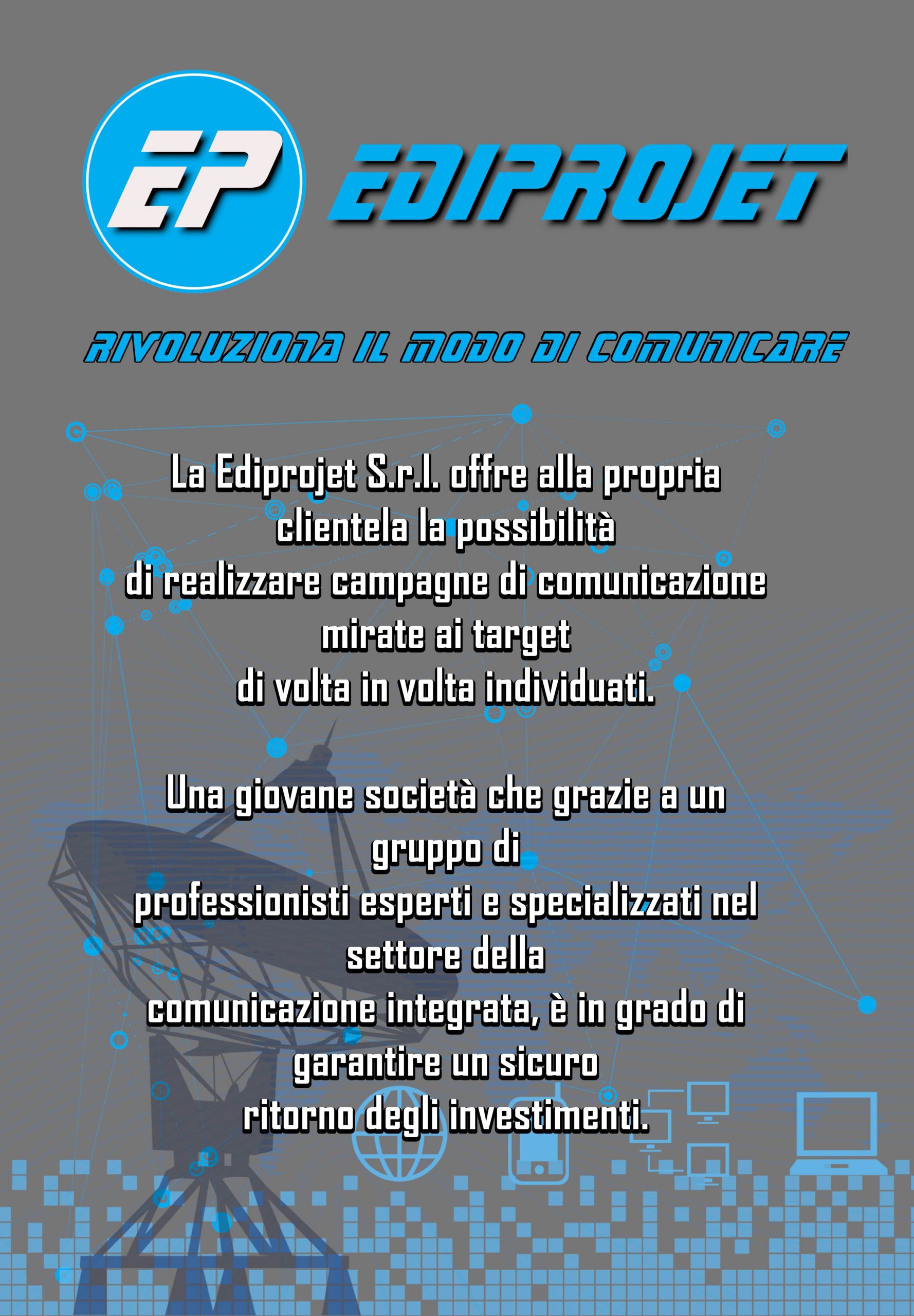Punirne uno per educarne cento
Rito abbreviato e pena ridotta. Ma il crollo del “Re dei maranza” illumina un disagio collettivo, non un caso isolato.
C’è un momento in cui la recita si interrompe e resta solo ciò che è vero. Per Don Alì, il “Re dei maranza”, quel momento è arrivato quando ha capito che il telefono non era più un trofeo, ma un oggetto sequestrato. Il video dell’aggressione al maestro — davanti alla figlia di tre anni e mezzo — non era più un contenuto da far girare, ma la prova che lo avrebbe portato in cella. E infatti è lì che si trova.
Ma la storia non nasce da quell’episodio. Quella è solo la scena più rumorosa. Prima c’erano già le sfide registrate, le provocazioni alle forze dell’ordine, gli appostamenti fuori da scuola, le clip costruite per screditare il docente. Tutto pensato per funzionare online, tutto calibrato per un pubblico preciso: ragazzini molto giovani, spesso minorenni, che lo seguivano come si segue un modello, non un coetaneo. Un pubblico che non ha ancora gli strumenti per distinguere la posa dalla realtà, la spacconata dal reato, la performance dalla responsabilità.
E qui sta il punto più pesante: lui lo sapeva. Sapeva che chi lo guardava era fragile, imitativo, affamato di identità. Sapeva che ogni gesto sarebbe stato copiato, amplificato, normalizzato. E invece di frenare, ha accelerato.
La cultura maranza e il suo pubblico vulnerabile
La cultura maranza vive di questo: un’estetica che diventa comportamento, un comportamento che diventa linguaggio, un linguaggio che diventa appartenenza. Piumini come corazze, branco come scenografia, tono perennemente sopra le righe. È un teatro continuo, dove il pubblico non è davanti a te ma dentro un algoritmo che premia ciò che disturba. E più disturbi, più sali.
In questo ecosistema, il maestro elementare era il bersaglio perfetto: un adulto che non può reagire, un simbolo dell’autorità “buona”, un personaggio che funziona bene in video. L’aggressione non è stata un gesto: è stata una puntata. E come ogni puntata, doveva essere ripresa. La bambina di tre anni e mezzo? Una comparsa involontaria. La scuola? Una scenografia. La realtà? Un set.
Poi la realtà ha smesso di collaborare. La polizia, l’arresto, il trasferimento in carcere, i profili social che spariscono come se bastasse cancellare un account per cancellare ciò che è stato. E ora la richiesta di perizia psichiatrica, il rito abbreviato, il processo che si avvicina.
Le responsabilità e le domande che restano
È qui che la frase antica torna utile: punirne uno per educarne cento. Non per intimidire, ma per ricordare che la società non è un palcoscenico, che la violenza non è intrattenimento, che la vita non è un contenuto da montare in verticale.
E allora le domande finali non riguardano solo lui. Riguardano ciò che abbiamo lasciato crescere mentre guardavamo altrove. Riguardano i ragazzi che lo seguivano come si segue un fratello maggiore, senza capire che stavano imparando un copione sbagliato. Riguardano gli adulti che hanno smesso di vigilare, convinti che un telefono fosse innocuo.
Quanti giovani stanno modellando il proprio carattere su figure che non hanno nulla da insegnare.Quanti confondono la visibilità con il valore, il rumore con la forza, la sfida con l’identità. Quanti “Re dei maranza” stiamo allevando senza accorgercene, solo perché l’algoritmo applaude ciò che la realtà punisce. Quanti adulti hanno delegato l’educazione a un feed che non conosce responsabilità. E soprattutto: quanto tempo ci vorrà per riparare ciò che abbiamo lasciato formare da uno schermo.
Torna alle notizie in home