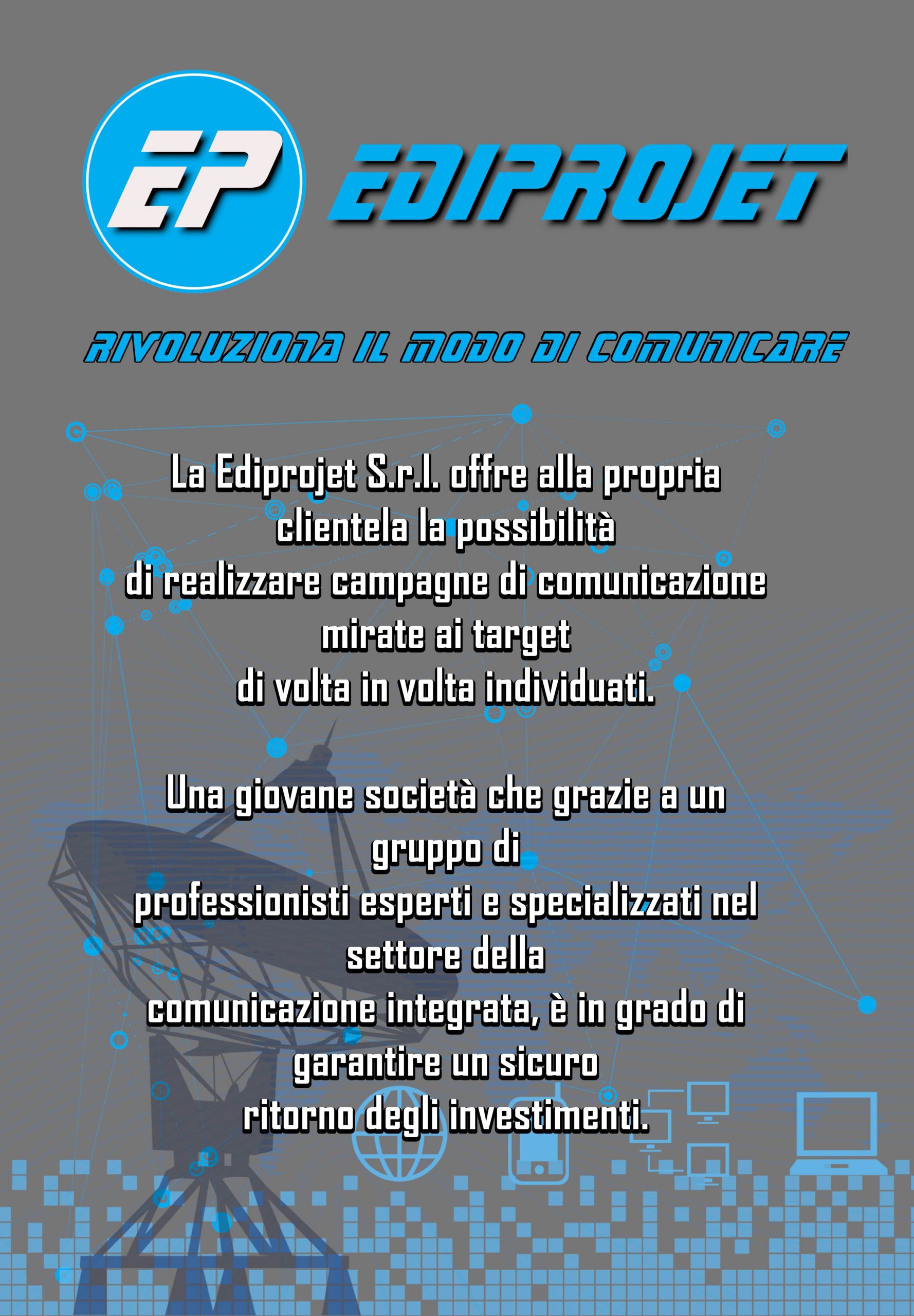Con il cuore in piazza, il silenzio sul martello
Torino, corteo per Askatasuna: un poliziotto aggredito con calci, pugni e un martello. Le parole scritte ieri da Ilaria Salis e l’ambiguità politica davanti alla violenza
I fatti, prima delle narrazioni
A Torino, durante il corteo a sostegno del centro sociale Askatasuna, un poliziotto è stato accerchiato e aggredito con calci, pugni e un martello. Un atto di violenza grave, deliberato, che non può essere ridotto a “tensione”, né liquidato come episodio isolato. Non c’è stata una degenerazione improvvisa, non c’è stato un fraintendimento, non c’è stato un eccesso emotivo: c’è stata un’aggressione organizzata contro un servitore dello Stato. Su fatti di questo tipo non esiste un contesto che possa assolvere. Non c’è nulla da salvare, da spiegare o da riformulare in chiave sociologica. Ogni tentativo di “contestualizzazione” serve solo a spostare l’attenzione dal punto centrale: una persona in divisa è stata colpita mentre svolgeva il proprio lavoro.
È qui che il dibattito pubblico dovrebbe fermarsi, respirare e chiamare le cose con il loro nome. Perché quando la violenza diventa un mezzo accettabile, o anche solo tollerato, non siamo più nel campo del dissenso, ma in quello della sopraffazione. Chi aggredisce un poliziotto non esprime idee: pratica violenza. Tutto il resto è una costruzione narrativa utile a tranquillizzare le coscienze.
Le parole di ieri e il problema della responsabilità
Ieri, mentre a Torino si svolgeva il corteo, Ilaria Salis ha affidato ai social un messaggio rivolto ai manifestanti:
«Purtroppo oggi non riesco a essere a Torino, ma con il cuore sono lì con voi.
Rispondere agli attacchi repressivi del Governo rilanciando sull’allargamento delle lotte sociali è la strada giusta da percorrere insieme a Torino e in tutta Italia. Buona manifestazione a tutte! Askatasuna»
È importante essere precisi: in queste parole non c’è un invito esplicito alla violenza. Ma c’è qualcosa di più insidioso, e politicamente più rilevante. C’è la costruzione di una cornice in cui lo Stato diventa l’aggressore (“attacchi repressivi”) e la piazza viene legittimata come soggetto che “risponde”. Una risposta che viene evocata senza mai essere delimitata, senza mai essere circoscritta, senza mai essere vincolata a un principio di legalità.
In quel messaggio non c’è una riga che richiami alla responsabilità.
Non c’è una parola sui limiti.
Non c’è una distinzione tra protesta e violenza.
Oggi, dopo bombe carta, roghi, scontri e l’aggressione a un poliziotto, manca anche una presa di distanza. E il silenzio, quando segue fatti di questa gravità, non è un dettaglio: è una scelta politica.
L’ambiguità come cifra culturale
Da anni una parte della sinistra politica e culturale evita accuratamente di chiamare queste azioni con il loro nome. Preferisce un lessico opaco, fatto di allusioni e rovesciamenti semantici: la repressione al posto dell’applicazione della legge, il conflitto al posto dell’aggressione, la lotta al posto della violenza.
È una strategia nota. Funziona perché sposta sempre il fuoco lontano dal gesto concreto. Così il colpo diventa “reazione”, il pestaggio diventa “tensione”, l’aggressione diventa “contesto”. In questo modo la violenza non viene mai davvero condannata: viene diluita, relativizzata, assorbita nel rumore di fondo.
Il risultato è un clima di ostilità permanente verso le forze dell’ordine, viste non come garanti della sicurezza, ma come simboli da colpire. E quando questo clima viene alimentato da parole pubbliche, da messaggi politici, da ammiccamenti ideologici, la responsabilità non è più solo di chi colpisce, ma anche di chi prepara il terreno.
Irresponsabilità organizzata
C’è una forma di radicalità che non rischia nulla. È quella che si esercita da lontano, “con il cuore”. Una radicalità che benedice le piazze, evoca la lotta, denuncia la repressione e poi, quando arrivano i calci, i pugni e il martello, si rifugia nel silenzio o nella retorica.
È una radicalità astratta, immacolata. Non sporca le mani, ma contribuisce al clima.
Non colpisce, ma normalizza. Non condanna, perché condannare costringerebbe a scegliere.
A Torino non c’è stata una risposta alla repressione.
C’è stata un’aggressione a un poliziotto.
Difendere le forze dell’ordine non è una posizione ideologica. È il minimo indispensabile di uno Stato di diritto. Tutto il resto, (cuori, slogan, lotte senza confini è rumore). E quando il rumore serve a coprire i colpi, non è più politica: è irresponsabilità travestita da militanza.
Solidarietà alle forze dell’ordine.
La violenza non è una lotta.
E il silenzio, a volte, è la forma più raffinata di complicità.
Leggi anche: Prendeteli e buttate la chiave
Torna alle notizie in home