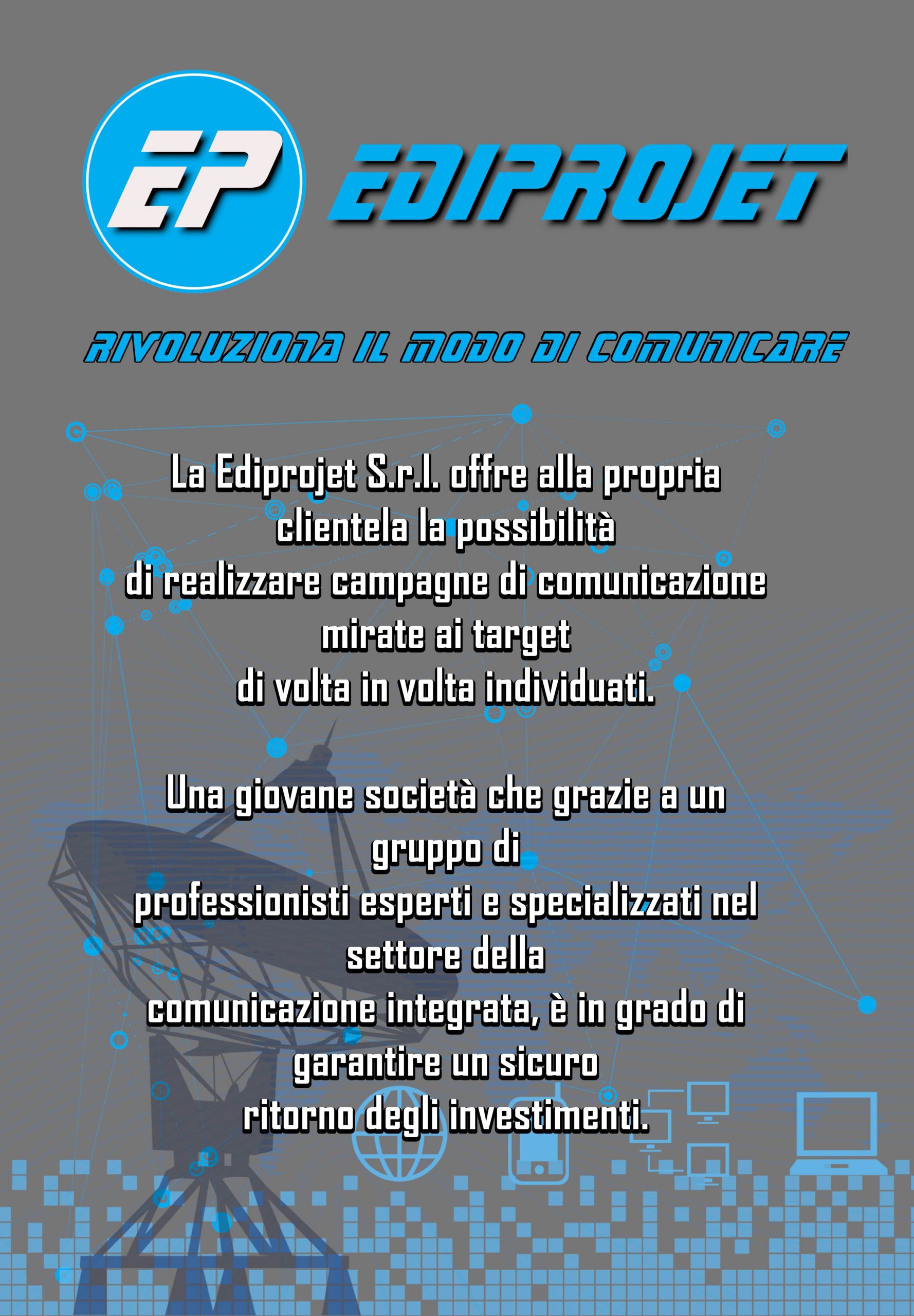Il lutto si addice ad Elettra, riscrittura profonda di un testo ambizioso
Il lutto si addice ad Elettra di Eugene O’Neill, messo in scena da Davide Livermore nella nuova traduzione di Margherita Rubino, è uno spettacolo imponente che affronta uno dei testi più ambiziosi del teatro americano del Novecento, collocandolo in un dialogo serrato con la tragedia greca e con la psicoanalisi freudiana. Non si tratta di una semplice trasposizione dell’Orestea di Eschilo, ma di una riscrittura profonda che innesta il mito degli Atridi nel cuore del dramma borghese americano, ambientato durante e dopo la guerra di secessione. La lunga durata dell’opera – tre parti, tredici atti, oltre tre ore e mezza di spettacolo – non è un virtuosismo, ma la misura necessaria per raccontare una discesa senza redenzione nei meccanismi della colpa e della ripetizione.
Al centro della vicenda c’è la famiglia Mannon, incarnazione di una rispettabilità solo apparente. Il generale Ezra Mannon, alter ego di Agamennone, torna vittorioso dal fronte e trova una casa già segnata dal tradimento: la moglie Christine, moderna Clitemnestra, è legata al capitano Adam Brant, figura di Egisto. La figlia Lavinia, equivalente di Elettra, scopre la relazione e diventa il motore della vendetta, spingendo il fratello Orin, Oreste novecentesco traumatizzato dalla guerra, a uccidere l’amante della madre. Segue il suicidio di Christine e, più avanti, quello dello stesso Orin, incapace di sostenere il peso della colpa. Lavinia, unica superstite, sceglie infine una vita di reclusione, condannandosi a un lutto eterno, senza alcuna possibilità di assoluzione.
Livermore legge questo intreccio non come una tragedia del fato, ma come una tragedia della psiche. Scomparsa la polis e il tribunale dell’Areopago, restano solo la famiglia e l’inconscio come luoghi di giudizio e punizione. Il mito antico è riconoscibile nella struttura e nei ruoli, ma è attraversato da un pensiero profondamente novecentesco: complessi edipici, pulsioni incestuose, ossessioni per i morti che continuano a vivere nella mente dei sopravvissuti. La domanda che attraversa l’opera – «Perché non possono morire i morti?» – diventa il vero cuore tematico dello spettacolo.
La messinscena si colloca in un tempo mentale più che storico. Pur partendo dall’ambientazione ottocentesca del testo, Livermore sposta l’immaginario verso la metà del Novecento, con costumi e atmosfere che evocano un noir americano sospeso tra melodramma e cinema. La scena, essenziale e simbolica, utilizza pochi arredi e una struttura di quinte sghembe chiusa da una grande superficie specchiante, che moltiplica e deforma le immagini, suggerendo il raddoppiamento delle identità e l’impossibilità di sfuggire al proprio riflesso. Le luci di Aldo Mantovani e l’ambiente sonoro di Daniele D’Angelo, che intreccia musica colta e standard popolari, accompagnano la vicenda come una colonna sonora emotiva, scandendo le tre parti del dramma.
La nuova traduzione di Margherita Rubino restituisce al testo una lingua scorrevole e incisiva, capace di sostenere la lunga durata senza perdere tensione. Centrale è il lavoro degli attori: Paolo Pierobon disegna un Ezra Mannon autorevole e vulnerabile; Elisabetta Pozzi offre una Christine complessa, sensuale e feroce; Marco Foschi interpreta un Orin spezzato dal trauma e dal senso di colpa; Aldo Ottobrino dà misura e ambiguità al capitano Brant. Ma è Linda Gennari, nel ruolo di Lavinia, a reggere l’intero arco dello spettacolo, attraversando una metamorfosi che la porta a identificarsi progressivamente con la madre odiata, fino alla solitudine finale.
Il lutto si addice ad Elettra, nella lettura di Livermore, si chiude senza catarsi. Non c’è pacificazione, non c’è perdono, non c’è un ordine nuovo che sostituisca il caos. Resta solo l’inevitabilità di un destino interiore, fatto di colpa e memoria, che imprigiona i personaggi e coinvolge lo spettatore come testimone impotente. Uno spettacolo rigoroso e ambizioso, che restituisce tutta l’attualità di un grande classico del teatro americano, capace ancora di parlare dei lati oscuri della famiglia e dell’impossibilità di liberarsi dal passato.
Renato Verga ilTorinese.it foto Federico Pitto
Torna alle notizie in home