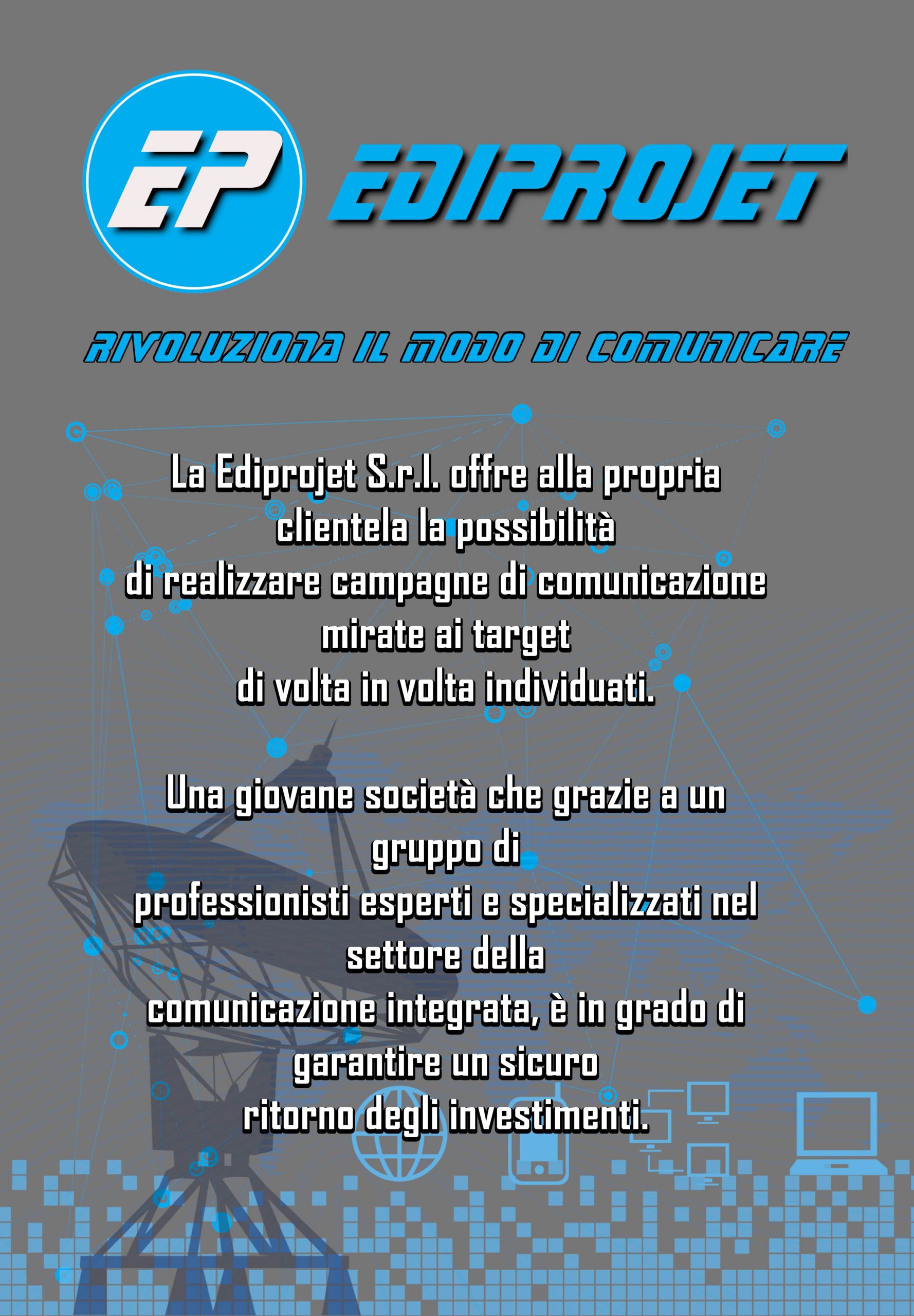L’illusione della forchetta “buona”: se la bioplastica diventa un alibi per non cambiare
di GIOVANNI BATTISTA RAGGI
Il gesto è automatico, quasi liberatorio. Finiamo la pausa pranzo, raccogliamo posate e piatti con sopra stampata la rassicurante fogliolina verde e gettiamo tutto nel contenitore dell’umido. Ci sentiamo virtuosi: abbiamo inquinato meno. O almeno, questo è ciò che crediamo. La realtà che si consuma pochi chilometri più in là, dietro i cancelli degli impianti di trattamento rifiuti, racconta una storia diversa, fatta di nastri trasportatori inceppati e di un colossale equivoco di fondo.
È il “paradosso della bioplastica“, l’elefante nella stanza del dibattito ambientale contemporaneo. Non stiamo parlando di un fenomeno di nicchia: secondo l’ultimo rapporto 2024 di Assobioplastiche, in Italia vengono immesse al consumo oltre 126.000 tonnellate di manufatti compostabili l’anno. Una filiera industriale d’eccellenza che vale oltre un miliardo di euro, ma che rischia di zavorrare la transizione ecologica se gli impianti non reggono l’urto.
Il primo nodo è tecnico. Esiste una confusione sostanziale tra ciò che è biodegradabile in natura e ciò che è compostabile solo in condizioni industriali (temperature elevate e umidità controllata). Nel caos delle etichette, il cittadino sbaglia spesso mira. Le analisi del CIC (Consorzio Italiano Compostatori) rilevano che nel bidone dell’umido finisce ancora una media superiore al 5% di materiali “intrusi”. Un errore di distrazione collettiva che costa caro: circa 140 milioni di euro l’anno spesi dai Comuni solo per separare e smaltire ciò che abbiamo mescolato male.
Poi c’è il conto alla cassa, che non torna. La “transizione dolce” verso la bioplastica ha un prezzo salato: produrre polimeri vegetali costa oggi dalle due alle quattro volte in più rispetto alla plastica tradizionale. Un sovrapprezzo per oggetti destinati comunque a diventare spazzatura dopo pochi minuti. Eliminare il monouso, dunque, non è solo un imperativo ecologico, ma una strategia di efficienza economica: la tazzina di ceramica si ammortizza, quella in bioplastica è una tassa continua a fondo perduto.
Ma il bilancio non è solo economico. C’è un capitolo più oscuro che meriterà approfondimenti futuri su queste pagine: quello della salute e delle risorse. Da un lato c’è l’incognita degli additivi chimici (come i PFAS), spesso usati per rendere impermeabili le vaschette in carta o fibra, che rischiano di migrare nel cibo o nel compost. Dall’altro c’è il falso mito dello spreco d’acqua: lavare una tazza consuma risorse, certo, ma gli studi sul ciclo di vita confermano che l’impatto è comunque nettamente inferiore a quello di estrarre, produrre e trasportare un oggetto nuovo ogni volta.
È qui che interviene la politica. Con il nuovo Regolamento UE sugli Imballaggi (PPWR), Bruxelles ha fissato un obiettivo draconiano: ridurre i rifiuti del 15% entro il 2040. Una cifra irraggiungibile sostituendo semplicemente il polimero fossile con quello vegetale.
Il rischio concreto è che la bioplastica diventi un formidabile strumento di greenwashing involontario, un alibi psicologico per non cambiare abitudini. La sfida dei prossimi mesi sarà togliere l’ipocrisia dal tavolo. L’etichetta “100% compostabile” non è un’indulgenza plenaria. La tecnologia ci offre un aiuto, non un alibi. Se non accetteremo che il vero “eco-friendly” è l’oggetto che non buttiamo via dopo cinque minuti, la rivoluzione verde resterà un costoso esercizio di stile. Perché al pianeta non servono rifiuti migliori: serve che smettiamo di produrne.
Torna alle notizie in home